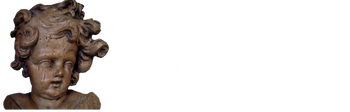Bottega di Giovanni Benedetto Castiglione, detto Il Grechetto (Genova, 23 marzo 1609 – Mantova, 5 maggio 1664)
Famiglia di pastori
Olio su tela, 72 x 98 cm
Con cornice, 87 x 112 cm
Giovanni Castiglione nasce a Genova nel marzo 1609, così come riportato da una serie di documenti relativi alla registrazione del suo battesimo. Iniziò giovanissimo ad avvicinarsi alla pittura, seguendo le indicazioni di maestri quali Giovanni Battista Paggi, Giovanni Andrea De Ferrari e Sinibaldo Scorza, con i quali lavorò per diverso tempo. Le sue prime opere giovanili mostrano il suo profondo attaccamento alla pittura animalista, estremamente diffusa all’epoca: questa tendenza si può notare in dipinti quali L’entrata degli animali nell’arca (Genova, Accademia Ligustica) e Noè fa entrare gli animali nell’arca, (Firenze, Gall. degli Uffizi, inv. 1336), ascrivibili alla prima stagione dell’attività del pittore. Il contatto con l’ambiente romano negli anni Trenta del 1600 cambia profondamente la visione artistica del Castiglione, profondamente affascinato dalle nascenti forme barocche del Bernini e dalla pittura classica di Poussin, che contribuiscono alla scoperta da parte del genovese di una nuova concezione artistica, che si nota particolarmente in dipinti come Satiro e ninfa e l’Adorazione del vitello d’oro. Dopo dei brevi soggiorni a Napoli e una lunga permanenza a Roma, nel 1639 il Grechetto ritorna a Genova dove si sposa e mette su famiglia, così come riportato in alcuni documenti notarili. Dopo un periodo di pausa artistica, il Castiglione realizza nel 1645 La Natività per la chiesa genovese di S. Luca, mostrando ancora un notevole attaccamento alle forme classiche ma interponendo una nuova dimensione spaziale in cui confluiscono suggerimenti colti dall’ambiente romano e napoletano. Identico discorso vale per i dipinti di ispirazione religiosa quali la Visione di S. Bernardo (Genova-Sampierdarena, S. Maria della Cella) e S. Giacomo che scaccia i Mori (Genova, oratorio di S. Giacomo della Marina; bozzetto a Petworth, coll. Wyndham). Ma sono questi gli anni in cui il Castiglione comincia a elaborare uno stile fantasioso non abbandonando i crismi della classicità: sullo sfondo di un mondo antico fatto di busti, vasi, rovine emergenti ricoperti da una vegetazione che quasi li nasconde alla vista, spuntano figure mitologiche quali ninfe o satiri che acquistano una dimensione quasi irreale e magica. Nel 1647 torna a Roma con la famiglia e gli anni di permanenza nella città eterna consolidano il suo avvicinamento all’arte barocca come testimonia l’opera Immacolata di Osimo (conservata oggi all’Institute of Art di Minneapolis; bozzetto a Windsor Castle, Biblioteca reale) e l’affermarsi di uno stile più fantastico-archeologico, rivelando tutta la profondità intellettuale e filosofica dell’artista così come si evidenzia nei Baccanali e Circe. Nel 1654 si trasferisce a Mantova, lavorando presso la corte dei Gonzaga. Secondo quanto riportato dalle lettere del fratello Salvatore, l’intesa tra i Gonzaga e il Castiglione non debba intendersi con una sorta di dipendenza ma come un legame non vincolante che lasciava all’artista libertà di movimento che di espressione. Castiglione fu noto anche per la sua attività di incisore, specializzato nella tecnica dell’acquaforte e inventore del monotipo: la sua tecnica luminosa e fortemente cromatica lo collocano tra gli incisori più apprezzati del Seicento. La produzione del Grechetto fu d'ispirazione per moltissimi artisti, basti pensare al napoletano Andrea De Lione, a Pier Francesco Mola e Pietro Testa, tutti accomunati da un temperamento che Luigi Salerno definì 'del dissenso' e a cui dobbiamo aggiungere il nome di Salvator Rosa. Appare quindi chiara la partecipazione a una tendenza intellettualizzante e criptica, che si oppone alla larga comunicazione e alla chiarezza richiesta dai dettami post-tridentini.
Questo dipinto, realizzato all’interno della bottega del Grechetto, presenta molte delle caratteristiche chiave della produzione animalista del maestro. Il ductus dell’artista è sfumato, a tratti indefinito, tutt’altro che accademico: allo stesso tempo, la raffigurazione degli animali risulta essere estremamente precisa. L’autore genovese si rivela, in questa scena, perfettamente in grado di rendere appieno l’umanità della famiglia di pastori, raffigurati in maniera realistica e in totale assenza di pietismo. Anche i colori chiari e radiosi si incanalano perfettamente nei dettami della vasta produzione animalier del Grechetto.












































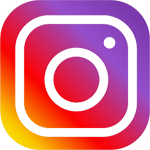
 Le Magazine de PROANTIC
Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine
TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato
Rivista Artiquariato