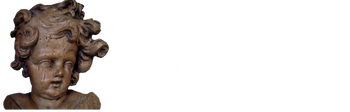Misure: cornice, cm L 121,5 x H 105 x P 5,5. Tela cm L 100 x H 81
L’opera, realizzata da pittore veneto attivo nella prima metà del XIX secolo, seguace di Francesco Guardi, raffigura la piazza di San Marco a Venezia, con la Torre dell’Orologio sullo sfondo. La veduta è infatti ispirata alla produzione artistica del celebre pittore Francesco Guardi (Venezia, 1712 – 1793) secondo uno scorcio più volte riprodotto dal maestro. Guardi la raffigurò in diversi suoi dipinti e, con questa inquadratura, se ne conoscono alcune versioni. La tela in oggetto riprende una versione che Guardi realizzò, firmandola, tra il 1760 e il 1770, oggi conservata in collezione privata. Il fulcro della composizione è la rinascimentale Torre dell'Orologio, imponente struttura della piazza, descritta con minuzia di particolari. La Torre è uno dei segni architettonici più celebri di Venezia: sovrasta come un arco di trionfo l’accesso alla nevralgica via commerciale della città, l’antica Merceria. Con il suo grande orologio astronomico, capolavoro di tecnica e di ingegneria, appartiene all’immagine stessa di Venezia e ne segnò la vita, la storia e il continuo scorrere del tempo. Fu edificata fra il 1496 e il 1499 e poi successivamente ampliata nel 1506 e nel 1757, fino a raggiungere la conformazione attuale. La costruzione della torre avvenne durante il governo di Agostino Barbarigo, che fu Doge di Venezia dal 1486 al 1501. Il suo stemma infatti decora ancora oggi l'esterno della campana e una statua del Doge inginocchiato era posta a destra del leone alato. Distrutta nel 1797, è ancora ben leggibile nel dipinto in oggetto. La piazza brulica di figure che, benchè piccole, sono rese con uno stile sciolto che ne accentua il movimento. Bancarelle con tende bianche suggeriscono un vivace mercato. Gli edifici che circondano la piazza sono descritti con diversi livelli di dettaglio, mostrando la tipica architettura veneziana dell'epoca. Sono visibili alti pennoni, che contribuiscono all'atmosfera della scena. Il cielo azzurro chiaro è movimentato da alcune nuvole. Alla fine del Seicento inizia, e si sviluppa per tutto il Settecento, il turismo europeo; nobili e borghesi benestanti visitano l'Italia per acquistare opere e oggetti d'arte e d'antiquariato o per approfondire quanto appreso sui libri. Le mete d'obbligo del Grand Tour sono Venezia, per l'unicità dei suoi ambienti, Firenze, per l'arte rinascimentale, Roma, per l'arte, le chiese e le memorie classiche, Napoli, la città italiana più grande a quel tempo e la Sicilia, per i templi greci e il suo clima mediterraneo. Si apre così un nuovo mercato artistico: si vuole un ricordo di ciò che si è visitato, una veduta, un monumento rappresentato in pittura. A Venezia si forma un'importante scuola di vedutisti dove emergono Canaletto, Bernardo Bellotto e Francesco Guardi. Francesco Guardi, dopo essersi formato presso la bottega del fratello Gianantonio, nel 1735 entra nella bottega di Michele Marieschi, pittore di vedute e di capricci, architetto e quadraturista, rimanendovi fino alla morte di questi nel 1743. Influenzato altrettanto dalla produzione artistica di Alessandro Magnasco e talvolta di Canaletto, si discosta dagli altri maestri verso un’espressione personale in cui propone l'interpretazione del dato reale soggettiva ed evocativa. Realizza immagini di città evanescenti e irreali, raggiungendo a volte una sensibilità quasi pre-romantica, verso un processo di costruzione della forma per via puramente cromatica, luministica, con ampio spazio a malinconiche e vibranti penombre. Pittore prolifico, muore nel 1783 nella sua casa veneziana. Il dipinto, molto decorativo, ben rappresenta la fortuna che le opere di Guardi ebbero, ampiamente ricercate anche negli anni a seguire la sua morte, in cui svariate committenze domandavano ai suoi seguaci di riproporre i suoi soggetti. Contestualmente alla valenza artistica vi è quella storica: si tratta infatti di una veduta che segna usi, costumi e architetture mutate nei secoli ma ben documentate in questa tela. L’opera è presentata in cornice antica con doratura non coeva.

















































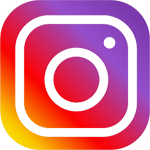
 Le Magazine de PROANTIC
Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine
TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato
Rivista Artiquariato