Salomé ed Erode con la testa del Battista
Scheda a cura del Prof. Rolando Bellini
È questo il caso in cui è opportuno introdurre l’olio su tela in esame, il reperto che si va recensendo, proponente in una bella ma un po’ sofferta cornice dorata coèva, Salomè Erodiade ed Erode con la testa del Battista, seduti come avventori a un tavolo e circondati da altri figuranti atti a trasfigurare un’osteria napoletana del XVII secolo nella reggia del re, muovendo da alcuni cenni biografici del più che indubbio autore, per gli indizi che se ne potranno trarre in merito al suo “fare”. Una pittura che richiama, dunque, nella conduzione talvolta un po’ affrettata come si confà a uno studio preparatorio forse d’un maggiore formato, uno specifico frangente e la sua cultura pittorica, un orientamento linguistico inconfutabile, stante l’indiscutibile presenza di un autore ben noto. L’opera difatti spetta senz’altro a Carlo Sellitto (1580-1614), l’artista che ha assorbito fra i primi in area napoletana la lezione caravaggesca, com’è comprovato nel dipinto ch’è oggetto di queste note critiche. Lo scenario artistico in cui costui si forma ed esordisce – dobbiamo pertanto dire – corrisponde grossomodo a quel momento e quel clima di passaggio tra una tarda maniera e il nuovo naturalismo che, a cavaliere tra ultimo scampolo del Cinquecento e il primo Seicento, avrà infine il suo alfiere nel Caravaggio. Precisamente in quest’empasse va a collocarsi, ma in bilico, il nostro pittore la cui identità corrisponde al secolo al nome di Carlo Infantino, altrimenti noto come Carlo Sellitto per aver adottato, tanto quanto il padre Sebastiano, pittore e indoratore originario di Montemurro (Potenza), il cognome matrilineare dei Sellitto. Il Nostro nasce a Napoli da Lucente de Senna, informa Prota-Giurleo (1952) e dal montemurlese Sebastiano che per primo lo indirizzerà all’arte. Viene battezzato nella parrocchia di S. Giovanni Maggiore il 10 luglio 1580 (Stoughton, 1977; Barbone Pugliese, 1983), muore poco più che trentenne a Napoli, il 2 ottobre 1614 (Prota-Giurleo, 1952). Dopo aver assunto i rudimenti del mestiere sotto la guida paterna, quindicenne collaborò con Girolamo Imparato all’esecuzione di un «quadro de una Madonna», su commissione del vescovo di Ariano Alfonso de Herrera (De Mieri, 2008). A ciò seguì il passaggio presso l’atelier del carrarese Giovanni Antonio Ardito, dove il giovane fu posto a «creato» (Prota-Giurleo, 1952), stando a Cesare Soriano, testimone alle nozze di Carlo con la vedova Porzia Perrone (30 marzo 1613), come si evince assumendo il testo della puntuale voce del Dizionario biografico degli Italiani. Un nodo un po’ ingarbugliato e che potrebb’essere sciolto riguarda il momento del primo salto qualitativo della sua parabola artistica. Giacché non è stata accertato su base documentale o secondo altri elementi probatori il dichiarato (dalle fonti e dalla prima letteratura) discepolato presso il mal documentato fiammingo Louis Croys, fortunato ritrattista attesta l’archivio (De Mieri, 2008), la cui dissipazione non permette tuttavia di quantificarne il portato figurativo all’interno del primo laboratorio creativo sellittiano. Mentre invece è possibile confermare altri nutrimenti che Sellitto poté contrarre dalla frequentazione dell’atelier e dell’ambito di riferimento, dove ebbe modo di formarsi anche una qualche competenza musicale grazie all’incontro con il compositore Giovanni Maria Trabaci (Prota-Giurleo, 1952), committente nel 1613 della S. Cecilia ora al Museo di Capodimonte, ma destinata alla cappella omonima nella chiesa napoletana di S. Maria della Solitaria (de Lellis, ante 1689, 2013; Causa, 2008). Tanto che, al momento del trapasso che lo colse trentatreenne, si ha certezza di un suo possesso – l’inventario dei beni che data 1614 – di «uno organo et uno ciambalo, [...] dui liuti, dua tiorbia et due chitarre» (Prota-Giurleo, 1952). Un secondo inciampo pare riferirsi ancora una volta alla cultura figurativa degli esordi di Sellitto, segnati, parrebbe, da una piena adesione alla tradizione tardomanieristica partenopea (Causa, 1995; De Mieri, 2008) che resta invece di superficie, tradendo altre germinazioni profonde, altri interessi e orientamenti occulti. Resta vero che il Sellitto esprime un lessico delocalizzato rispetto a un ricco epicentro come la stessa Napoli e lontano dai fasti romani. Potrei anche dire: un lessico regionale e almeno in parte, dialettale, seppur innervato di accenti desueti che potrebbero pur riferirsi al Croys – come attesta la Madonna del Rosario e santi nella chiesa domenicana di S. Maria del Popolo a San Chirico Raparo, borgo potentino a poche miglia da Montemurro (De Mieri, 2008) – e con maggiore evidenza ad altri rappresentanti, più documentati, della colonia fiamminga attiva in Napoli in questo tempo, quali Dirck Hendricksz e Aert Mijtens. Questi assunti stemperano e al tempo stesso confermano l’altro e più sentito orientamento del Nostro, facente capo, sullo scorcio del Cinquecento, all’opaco, vago e un po’ artificiale naturalismo ‘riformato’ di Fabrizio Santafede. Sellitto, d’altro canto, ebbe a collaborare, nel 1598, con il Santafede alla doratura – lui, figlio di un valido doratore – dell’ancona con l’Immacolata Concezione per la chiesa dei cappuccini di Aversa (Prota-Giurleo, 1952). Quest’inclinazione che va traducendosi in un pathos tra il devozionale e il popolare che si somma all’inferenza dialettale foriera in questo caso d’un più schietto e laico lessico figurativo, liberandosi da ogni suggestione derivante da quest’incontro, trova conferma nella susseguente maturazione sua di cui è testimone la coeva Madonna degli angeli tra i ss. Francesco d’Assisi e Antonio di Padova della chiesa di S. Nicola di Bari a Lauria Superiore (Potenza), correttamente attribuita a Sellitto da Maria Vittoria Regina (2004). Sennonché, emerge pure un sentore baroccesco dei santi e dei cherubini (De Mieri, 2008) che torna ad allargare l’orizzonte dei possibili nutrimenti artistici del Sellitto, predisponendolo, a sua stessa insaputa al momento, all’ulteriore scarto che a breve lo travolgerà. Tutto il contendere, in vero, ruota sia per il prima che s’è sommariamente riassunto appoggiandoci alla letteratura sia per il dopo su cui verremo a insistere, sull’opera sua firmata, la Madonna del suffragio con le anime purganti e donatore della chiesa di S. Luigi Gonzaga ad Aliano (Matera). La tela è ben nota in virtù della presenza “in abisso” del tanto apprezzato ritratto del committente; un buon ritratto – richiamante molti autori napoletani e romani, ma anche d’altra provenienza – comprovante l’avvento del genere che fa appunto del “ritratto” un nuovo e fecondo tema pittorico e un punto di forza del Nostro. Questo stesso ritratto attrasse Ferdinando Bologna, chiamandolo a indagare questa personalità che fiancheggerà il Caravaggio partenopeo. Sellitto appare essere qui aggiornato e consapevole del nuovo che avanza a tal segno da cercare pure di smarcarsi un po’ dall’ombra caravaggesca che lo sovrasta, «già intinto [com’è] di ‘verità’ schiettamente caravaggesca», ma incline ai timbri ispanici come lascia intendere l’acuto appunto di questo studioso che, recensendo la pala, osserva: «si scambierebbe con un pezzo di pittura sivigliana o proto-velazqueña» (F. Bologna, 1991). Mentre invece il brano dei cherubini che sbucano dalle nubi ritorna alla lettera nella devozionale Madonna della Vallicella della quadreria dei Girolamini (Porzio, 2013b), suggerendo altri orientamenti e un passo indietro a cercar di recuperare una figurazione meno audace e ruvida, corriva e popolareggiante. Come si spiega sennò il S. Bruno in preghiera davanti al Crocifisso del Musée des Beaux-Arts di Strasburgo (Causa, 1995)? Trattasi d’un dipinto di evidente autografia sellittiana, a mio parere, che azzarda una contaminazione di forme e di pigmenti, di ombre e di costrutti spaziali appoggiati alla gestualità messa in atto dal santo, intentando forse un qualche rapido consuntivo per poter più liberamente assumere il rivolgimento in atto tentando di stabilire una propria cifra stilistica. Quantunque si debba riconoscere in questo decisivo momento di transizione e di evoluzione o maturazione filo-caravaggesca in Sellitto una qualche difficoltà e una evidente diffidenza proprio nei confronti della tanto rivoluzionaria rivelazione caravaggesca. È così che la sua pittura, pur azzardando brutalismi figurali consoni a meglio assorbire il caravaggismo del momento, manifesta una sordità di fondo proprio nei confronti del nuovo astro sorgente, che perdurerà. Nulla, a conferma di quanto si va dicendo, lascia trapelare nella pittura del Nostro un’inferenza sinergica con le abbreviazioni e i riduzionismi plastici e drammatici che ben si confanno alla stessa conduzione pittorica dirompente del Merisi. Ben più debole è in Sellitto la restituzione puntuale del vero, assunto in presa diretta, sull’esplicito esempio offerto dal Merisi. Vale davvero la pena, a questo punto, di richiamare l’attenzione su sommessi richiami fiammingheggianti che si manifesteranno più schiettamente in un collaboratore e amico del Sellitto, il più giovane Filippo Vitale, transitante egli pure nella bottega del Croys (G. Porzio, 2012), nella misura in cui sembrano lasciar trapelare nel Nostro una volontà di autonomia rispetto al portato caravaggesco e alle sue varie declinazioni partenopee del tempo che, di fatto, non ha grande fortuna generando esiti assai fragili. In ogni caso, un confronto stringente con Vitale che gli è amico – tanto è vero che il suo primogenito sarà tenuto a battesimo dal Nostro e verrà chiamato Carlo (Prota-Giurleo, 1952; D.A. D’Alessandro, 2008) – aiuta a meglio inquadrare lo stile sellittiano. L’elemento distintivo di questo stile è comunque quello che accosta già in termini decisi, in questo frangente, Sellitto a Caravaggio, se guardiamo agli altri artisti napoletani che si rivolgono al Merisi nella speranza di cavarne un rinnovamento. Egli opacizza e addensa le figure, decostruisce le forme, affiancandosi in questo ai seguaci di Spagna del Caravaggio attivi nel napoletano. Ma certo, il paradigma indiziario che si va ricercando si complica. È dunque il caso di riportare un brano della puntuale biografia artistica del Sellitto in cui si commenta con dovizia il S. Bruno in preghiera: «la paternità sellittiana [del san Bruno] si rivela nei sottosquadri angolosi del panneggio, nella caratteristica articolazione prospettica delle dita, nell’indagine impietosa delle carni flaccide e grinzose del santo e persino nella superba ambientazione paesistica, gravida di umori nordici», che dichiaratamente presenta un aggiornamento sulle direttive caravaggesche. In una data interessante anche pel Merisi, il 1607, quand’ormai il nostro pittore ha raggiunto una sua autonomia e dunque una più marcata maturità artistica che è il fondamento su cui impianterà la propria personale interpretazione del caravaggismo (...). Una singolare quadratura del cerchio? Del resto, proprio il Vitale si farà carico di curare la vendita di parte dei beni del Sellitto alla morte prematura di quest’ultimo, collaborando forse all’inventario redatto nel 1614 (Mostra didattica..., 1977). Ora si dovrà pur rilevare lo scarto evolutivo del suo stile, e al contempo una persistente resistenza a cogliere da parte del Sellitto non già le invenzioni formali e pittoriche più eclatanti e innovative e perciò cariche d’una trasgressività imbarazzante del fare caravaggesco che il Nostro traduce in un tono basso, popolaresco e, in fondo, assai meno nocivo, quanto il senso della forma caravaggesca, il sapore della pittura caravaggesca, declinate piuttosto in una formatività più apparente che sostanziale e tuttavia d’una sua convincente forza, di una timbricità peculiare. Certo, dialettale e per così dire partenopea e che va traducendosi viepiù in una conduzione pittorica vicina – si è visto – a quella degli spagnoli attivi in Napoli e nell’intero vicereame, oltre che a Roma donde proveniva, transfuga, l’affannato Caravaggio. Un dipingere sellittiano che, perlomeno in questo momento cruciale per la sua arte, sembra dare ragione pure dei ricorsi fiamminghi poc’anzi segnalati, pur attivi sottobanco e in costante rarefazione, come confermerà l’esito delle opere che seguono. Cosicché il nostro Sellitto, proprio nel prendere partito per la falange dei caravaggeschi spagnoli più rudi e sanguigni, più espressionistici e cupi, cercando al contempo di separarsene e fare parte per se stesso, rompe sommessamente anche con Caravaggio. E questo ci accosta con maggiore sicurezza all’opera in esame. Vediamo perché lasciandoci guidare, ancora una volta, dalla asseverata biografia artistica del Sellitto. L’apice della parabola artistica di Sellitto è compreso tra il 1608 e il 1612 e poco oltre, quand’egli fu chiamato a decorare la cappella «intitulata sotto il nome di San Pietro» dei bergamaschi Pietro, Giovan Domenico e Annibale Curtoni in S. Anna dei Lombardi a Napoli (Prohaska, 1975; D. de Conciliis et al., 1977) di cui restano le sole due tele laterali, La consegna delle chiavi e L’apostolo Pietro salvato dalle acque, trasferite nella vicina S. Maria di Monteoliveto a seguito del crollo della chiesa nel 1798 (Spinosa, 2005) e pure la pala d’altare – ci informa la storiografia – raffigurante «la Vergine santissima con l’apostolo san Pietro et un altro santo», il tondo nella volta con la «Crocifissione di san Pietro» e «i due [quadri] piccioli» al di sopra dei laterali, «in uno con la figura di San Francesco, nell’altro di San Domenico» (Celano, 1692, 2010), il primo dei quali è stato collegato al S. Francesco in atto di ricevere le stimmate di collezione privata, recentemente tornato alla luce (Porzio, 2011 e 2014). Per l’economia del nostro dire ha maggiore rilevanza tuttavia – mettendo da una parte la ritrattistica che lo rese celebre a Napoli e di cui restano minime testimonianze: il Ritratto di Adriana Basile presso l’antiquario Porcini a Napoli (Bologna, 1991; Porzio, 2017), eseguito poco prima del trasferimento della celebre cantante, nel maggio del 1610, alla corte mantovana di Vincenzo Gonzaga cui era con molta probabilità indirizzato – il secondo soggiorno napoletano di Merisi (1609-10), allorquando, verosimilmente, Carlo Sellitto ebbe forse modo di incontrare l’artista milanese già celebre, tanto che sul suo operato romano esprimerà un giudizio assai lusinghiero – ben conosciuto – il contemporaneo Carel van Mander (“Opera anche un Michelangelo d Caravaggio, il quale, a Roma, fa delle cose meravigliose…”). L’incontro tra il Caravaggio e il Sellitto parrebbe dunque verificarsi nel cantiere di S. Anna dei Lombardi, per il quale Caravaggio, com’è noto, realizzò tre quadri, oggi perduti: vale a dire le opere per la cappella Fenaroli (M. Cinotti, 1983). Al 1610-11 può essere ascritta a mio avviso, forse proprio a seguito di una tale esperienza, ovvero autonomamente rispetto a quest’incontro pur incisivo per il nostro Sellitto, una nuova maturazione filo-caravaggesca del Sellitto, ma già venata da altre attenzioni che porteranno il Nostro di lì a breve verso i bolognesi e alla scoperta di Guido Reni: è intorno a questa data che forse si colloca il S. Antonio di Padova e angeli della chiesa della Ss. Annunziata di Arienzo (Petrelli, 1985), di cui è stata identificata di recente una seconda redazione, divisa in frammenti tra il Museo Antoniano di Padova e il mercato antiquario, e realizzata, al pari della prima, sembrerebbe, con il concorso della bottega (Porzio, 2013a). Opera che propone una impostazione, una organizzazione illuminotecnica, un’economia figurale assonanti a loro modo con quanto si va esaminando quantunque se ne discosti per una maggiore secchezza. La presenza del Reni a Napoli, nel 1612 (F. Bologna, 1960), può ben motivare quest’attrazione nel Nostro – peraltro già in caccia di altri nutrimenti nel ’10 – che guadagna, appunto intorno a questa data, una rilevanza programmatica e dunque una maggiore evidenza. Al tempo stesso essa giustifica con l’inquietudine anche le assunzioni pur circospette che Sellitto opera rivolgendosi appunto al Reni nel corso del 1612 al quale chiede, evidentemente, di restituire un po’ del perduto “decoro” alla sua figurazione. Se ne ha conferma nella S. Cecilia del Museo di Capodimonte. L’opera che si osserva e di cui si vorrebbe tentare una lettura critica convincente inizia a trovare così i suoi riferimenti, quest’incontro macabro attorno a un tavolo tra la peccaminosa Salomè e la perfida madre e il loro re, racchiudendo in sé tutti gli elementi indiziari sin qui richiamati, pare cadere presumibilmente dopo il 1612, in linea con lo sviluppo riscontrabile tra 1610 e 1612, quando Sellitto propone un’ancor più caravaggesca Adorazione dei pastori – afferente al complesso napoletano di S. Maria del Popolo agli Incurabili (Prohaska, 1975; Pacelli, 1984), a lungo attribuita, a riprova dell’intonazione merisiana dominante, a Battistello Caracciolo: al seguito della iscrizione dichiarata da Bernardo De Dominici (1742-1745 circa, 2003) – che, purtroppo, si sottrae al desiderato confronto con il nostro reperto giacché non si lascia leggere correttamente, stante lo stato indigente in cui versa. Viceversa l’opera in esame mostra una condizione fisica o materiale buona, anzi invidiabile. Essa consente una lettura testuale corretta, favorisce un esame formale puntuale. Ne discende per quanto mi compete la convinzione che si tratta di un autografo di Carlo Sellitto tra i migliori e dunque uno dei ritrovamenti dell’ultimo tempo più siognificativi. Non resta allora che misurarne l’effettiva consistenza e qualità formale per stabilire una datazione più precisa, stante la già acquisita autografia sellittiana. Non resta che definirne l’efficacia pittorica e, per sincerarsi in merito a un eventuale slittamento un po’ in avanti della data di esecuzione, una ulteriore verifica. Infatti, converrà tentare altri pur rapidi confronti con i più tardi prodotti sellittiani: le opere ancor più mature, le opere conclusivo dell’artista. Si dovrà in ogni caso riconoscere nel dettato della nostra tela un’ibridazione arricchente d’altre inferenze in linea con l’ultima manifestazione stilistica sellittiana. Com’è attestato, poniamo, dal S. Carlo Borromeo eseguito per la cappella Ametrano in S. Aniello a Caponapoli e ora anch’esso a Capodimonte (Causa, 2008), di cui è nota una seconda versione. Sono quest’ultime opere, unitamente alla bella e al solito un po’ ruvida e selvatica Maddalena penitente, sempre esposta a Capodimonte e che raffigura sicuramente un ritratto muliebre (Porzia, forse?) i dipinti del Sellitto che ho conosciuto e apprezzato per primi, condizionando il mio stesso approccio ermeneutico, anche perché veduti assieme all’architetto del Museo di Capodimonte, Ezio De Felice. Ricordo che l’architetto De Felice ne era persino affascinato riscontrandone – e rivendicandone – un’appartenenza al clima partenopeo tutt’altro che superficiale. Ebbe anche modo di convincermi a riguardare l’opera di Carlo Sellitto con altri occhi. Debbo dunque a questo remoto dialogo l’accensione di un processo conoscitivo che, anni dopo, mi ha fatto riconoscere, finalmente, il particolare caravaggismo agente in Sellitto che esalta le sgrammaticature formali, le accidentalità e le contraddizioni figurali in funzione, parrebbe, di un lessico autoreferenziale, ben affermato specie nell’ultimo Sellitto. Oggi posso trarre anche da questi dipinti di Capodimonte assonanze di per sé parlanti con il dipinto che vado esaminando. Un’opera in cui pare manifestarsi lo struggente disfacimento dello spazio che si fa vuoto inerte e una paritetica riduzione figurale che si traduce in forme governate da un certo riduzionismo eclatante che questo spazio avvolgente contiene ed esalta. All’interno però di una organizzata impaginazione o composizione del gruppo delle figure, in linea con una articolazione semplificata o essenziale che prevale, peraltro, nell’attività tarda del Nostro. Questa nostra tela denuncia presenze caratterizzate da una qualche rigidità e dalle proverbiali sgrammaticature, nonché una posizione o dislocazione spaziale dei personaggi che ancora va cercando una più convincente collocazione. I personaggi raffigurati rispondono, di fatto, a un agire teatraleggiante, governato da gestica e prossemica, e paiono recitare un po’ impacciati o ingessati un copione già scritto. Puntuali orientamenti compositivi anteposti alla stessa composizione pittorica trapelano dal fatto che tutte le figure sono ancorate al volume prismatico del tavolo, vestito d’un panno cromaticamente accostabile ai costumi dei figuranti e certo scelto anche per ragioni allusivamente simboliche. Su di esso si impone, poi, un dettaglio di natura morta che funge da specchio illuminotecnico in grado di restituire le fonti di luce direzionata che governano la percezione e di mostrare la valentia del pittore. Tornano i ritratti, nei personaggi disposti su piani paralleli o intersecantesi nel disporsi attorno al tavolo che occupa il campo centrale dell’opera, secondo uno schema compositivo in via di verifica o costruzione (si è detto: allestito in questi termini secondanti uno schema un po’ rigido probabilmente per essere tradotto in un maggiore formato). Si manifestano pure le ricorrenti citazioni o gli imprestati sin qui richiamati che ne rafforzano l’ascrizione e una probabile datazione tarda. L’opera, in ogni caso, riesce tanto particolare da risultare d’una forza persuasiva accattivante. Attrattiva al di là del soggetto o tema, anche in virtù del fatto che si ha in essa il sentore d’una intenzione pittorica che cerca di superare il peso del lascito caravaggesco pur tanto catturante e anzi pienamente dominante in questo giro di anni, ma ormai svuotato e affiancato da più deboli e vaghe istanze che riescono in qualche modo contaminati. Questo denuncia forse una data verso il 1613. E va manifestando pure un assorbimento ammirato e tuttavia filtrato dei modelli caravaggeschi e una sommessa ritrosia o un’insofferenza velata nei confronti degli ardui modelli del maestro lombardo, segnalata pure, a mio parere, dall’intorpidente e invasiva suggestione prorotta dai caravaggeschi spagnoli attivi a Napoli, oltre che da curiosi richiami com’è per il Reni, per altri ricorsi contingenti, di cui si ha un riverbero anche nel nostro quadro. Se infine vado comparando questa tela con le estreme opere sellittiane – lavori lasciati incompiuti per la prematura dipartita come come un Crocifisso che è stato esposto nella chiesa napoletana di S. Maria in Cosmedin a Portanova (P. Leone de Castris - S. Guida, 1977) e il S. Antonio di Padova con Gesù Bambino già in S. Nicola alla Dogana, oggi nella basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte – e con i testi poc’anzi richiamati che risalgono a un tempo anteriore, ecco che trovo altre conferme della autografia sellittiana del nostro reperto. E una conferma in merito all’ipotetica datazione. Un dipinto di ottima resa e inconfondibile fattura che esprime di per sé una decisa espressività, una convincente fattura, la quale ben testimonia l’affermata nomea che il nostro artista ha guadagnato nel suo ultimo tempo e giustifica, infine, l’acquisizione d’un suggerimento autobiografico offerto dal Caravaggio e certo non facilmente adottabile: il personaggio in controparte che in parte si nasconde dietro il figurante con cappello e il re Erode, seduto in primo piano, è molto probabilmente lo stesso Carlo che, in questo caso, documenta i suoi trent’anni e la sua partecipazione all’evento biblico, adottando appunto, ma non senza un certo estro, l’esempio caravaggesco nell’autoproporsi all’interno del dipinto. Il sin qui congetturato, pertanto, ne riafferma anche la possibile datazione: si è di fronte a un’opera di Carlo Sellitto ascrivibile all’ultima sua stagione, attorno e anzi subito dopo il 1612. Dunque molto probabilmente tra quest’ultima data e, poniamo, i primi mesi del 1613. Il sin qui detto, debbo aggiungere a margine, deve molto agli studi che precedono e in particolare, at last but not least, agli appunti, sempre illuminanti, di quanti ho menzionato a vario titolo (richiamandoli per passione storiografica anche quando non concordavo pienamente con gli esiti loro).

































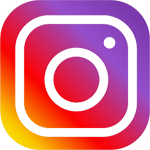
 Le Magazine de PROANTIC
Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine
TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato
Rivista Artiquariato